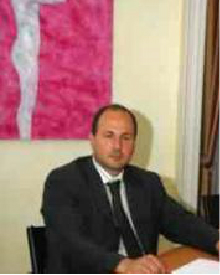Ai sensi dell’art. 1 delle disposizioni sulla legge in generale sono fonti del diritto le leggi, i regolamenti e gli usi. Nonostante il codice civile del 1942 sia stato emanato prima della Costituzione repubblicana e ancor prima dell’avvento del diritto comunitario (oggi diritto dell’Unione europea), l’elencazione delle fonti del diritto di cui alle preleggi non ha subito adeguamenti legislativi rispetto all’emersione delle nuove fonti normative.
Le norme comunitarie, in particolare, rivestono in ciascuno degli Stati membri dell’UE un ruolo determinante nella gerarchia delle fonti, seppur in maniera particolareggiata in considerazione dei loro diversi sistemi costituzionali.
La materia della responsabilità dello Stato per violazione del diritto comunitario concerne tutta una serie di conseguenze derivanti dal mancato, tardivo o inesatto adempimento o trasposizione di una fonte di derivazione comunitaria da parte dello Stato legislatore (centrale e regionale), dello Stato giurisdizione oppure di una pubblica amministrazione.
Questa materia è una di quelle in cui maggiormente si evince l’influenza del diritto comunitario in quello italiano, soprattutto nel macrosettore della responsabilità civile della pubblica amministrazione.
Per poter analizzare e comprendere gli aspetti che involgono il presente argomento, con particolare riferimento all’elemento soggettivo dell’illecito, occorre premettere delle brevi considerazioni sulle fonti del diritto unionale, su come queste si rapportano con quelle interne e, in generale, sul rapporto intercorrente tra diritto dell’Unione europea e diritto interno su cui la Corte Costituzionale, da un lato, e la Corte di giustizia dell’Unione europea, dall’altro, si sono schierate su opposte posizioni sin dal recepimento in Italia del Trattato CEE, avvenuto nel 1957.
La fonte di primo grado del diritto dell’UE è detta anche diritto originario e comprende i Trattati istitutivi, nonché gli atti successivi che li hanno modificati o completati.
Alle fonti di primo grado, che insieme alle fonti di secondo grado formano il diritto scritto, devono aggiungersi i principi generali del diritto enunciati dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, che costituiscono il diritto non scritto.
Gerarchicamente subordinato ai trattati è il diritto derivato che costituisce fonte di secondo grado, comprendente tutte le norme giuridiche emanate dalle istituzioni dell’Unione per la realizzazione degli obiettivi posti in essere dal diritto originario.
Tra le norme giuridiche di secondo grado, quelle che rilavano in questa sede sono i regolamenti e le direttive. Ai sensi dell’art. 288 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione (TFUE, ex Trattato istitutivo della Comunità europea del 1957), i regolamenti sono atti a portata generale, completi e obbligatori in tutti i loro elementi nonché direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri.
Essendo completi non necessitano, quindi, di recepimento.
Le direttive, invece, ai sensi dell’art. 249 TFUE, vincolano lo Stato membro cui sono rivolte per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salvo restando la competenza e la discrezionalità degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi per darvi attuazione.
Le direttive, a differenza dei regolamenti, hanno efficacia mediata poiché per creare diritti ed obblighi per i cittadini necessitano di una disposizione nazionale di recepimento.
Normalmente la direttiva fissa un termine entro il quale lo Stato è tenuto a conformarsi agli obblighi contenuti nella direttiva stessa.
In caso di mancato recepimento della direttiva nel termine assegnato allo Stato per darvi attuazione, la stessa non entra in vigore.
Qualora però contenga in alcune sue disposizioni obblighi sufficientemente chiari, precisi e incondizionati a carico dello Stato, atti a definire diritti che i singoli possono far valere proprio nei confronti dello Stato, produce effetti diretti nell’ordinamento interno degli Stati membri cui è indirizzata.
Si tratta delle direttive dettagliate o particolareggiate che, in quanto auto-esecutive e immediatamente vincolanti, non necessitano di recepimento.
Occorre evidenziare che, nonostante le direttive dovrebbero limitarsi a enunciare principi e criteri generali, nella prassi presentano sempre più frequentemente un carattere contenutisticamente dettagliato che ha finito per limitare la discrezionalità dello Stato membro alla sola scelta della forma giuridica, legislativa o amministrativa, dell’atto di recepimento.
L’efficacia diretta delle direttive riguarda però solo i rapporti tra i cittadini e lo Stato (effetto verticale delle direttive) poiché la responsabilità per il mancato recepimento nei termini è configurabile solo in capo allo Stato inadempiente, al quale potrà essere chiesto il risarcimento dei danni da mancato recepimento della direttiva.
Quindi, la Corte di giustizia ha posto l’accento sull’assenza di qualsiasi effetto orizzontale delle direttive non attuate, non potendo, cioè, i diritti riconosciuti dalla direttiva esplicare effetti tra soggetti privati.
Come si vedrà in seguito, due sono le procedure che consentono alla Corte di giustizia di pronunciarsi in merito ad un’eventuale responsabilità di uno Stato per inadempimento degli obblighi nascenti dalla loro partecipazione all’Unione, il rinvio pregiudiziale e la procedura di infrazione. In definitiva, siccome i regolamenti e le direttive dettagliate sono immediatamente esecutivi, il problema dell’inadempimento, dell’errato adempimento e della mancata trasposizione di un atto unionale nell’ordinamento interno, si pone solo per le direttive prive del carattere dell’auto-esecutività.
A differenza dell’ordinamento italiano, il TFUE non prevede una gerarchia delle fonti di secondo grado poiché si limita, ai sensi dell’art. 288, a indicare il tipo di atto che le istituzioni devono adottare per svolgere la propria azione a seconda della natura, del tenore dell’azione prescelta e delle finalità che si intendono perseguire. Quando il trattato non indica il tipo di atto da adottare, la scelta è lasciata alla discrezionalità delle istituzioni comunitarie.
A tal proposito è importante fare una considerazione. Se è vero che non è prevista una gerarchia delle fonti di secondo grado, è anche vero che il diritto derivato è pur sempre subordinato al Trattato.
Gli organi legislativi comunitari possono porre in essere delle direttive dettagliate solo nell’ambito di quelle determinate materie che possono essere disciplinate anche dai regolamenti.
Ciò in quanto è il Trattato, quale fonte di primo grado, a stabilire se su una materia gli Stati membri possano esercitare una discrezionalità quanto forma e mezzi o se invece devono accettare tout court un atto direttamente applicabile. Detto questo, gli organi legislativi comunitari non possono disattendere una disposizione del Trattato adottando un regolamento o una direttiva dettagliata in una materia in cui ciò non è previsto dalla fonte di primo grado, perché altrimenti violerebbero il Trattato.
Quindi, gli Stati membri interessati a dimostrare tale violazione potrebbero invocare l’art. 340 c.2 TFUE per far valere legittimamente una responsabilità extracontrattuale delle istituzioni comunitarie per il mancato rispetto delle sfere di autonomia interna guarentigiata. Tale articolo rappresenta l’unica disposizione presente nel Trattato in tema di responsabilità extracontrattuale ed è relativa ai danni causati dalle istituzioni dell’UE o dai suoi agenti nell’esercizio delle loro funzioni.
Dalle considerazioni appena fatte emerge che l’ordinamento unionale, concepito come ente sovranazionale dotato di propria personalità giuridica a livello internazionale, rappresenta un fenomeno sui generis rispetto alle altre organizzazioni internazionali, le cui regole del diritto consuetudinario e pattizio si rivolgono soltanto allo Stato e alle organizzazioni internazionali, mentre gli individui, pur essendo considerati beneficiari di alcune norme, non sono considerati soggetti di diritto.
Il diritto dell’UE, invece, conferisce anche ai cittadini una serie di diritti e di obblighi. Ecco la ragione che ha reso necessaria la predisposizione di un sistema di garanzie in grado di consentire al singolo di far valere in giudizio i propri diritti e di ottenere un ristoro per la violazione subita.
Durante i primi anni di esperienza europea da parte del legislatore italiano non poche perplessità si sono mosse sul fenomeno del recepimento degli atti europei. L’idea che un atto approvato da organi diversi dal Parlamento potesse addirittura rendere inapplicabile una normativa nazionale costituiva un elemento anomalo nel sistema delle fonti così come concepito dalla dottrina costituzionalistica.
Solo al termine di un lungo contrasto giurisprudenziale, la Corte Costituzionale ha riconosciuto la prevalenza delle norme unionali su quelle interne, in linea con le pronunce della Corte di giustizia, collocandole in una posizione di subordinazione ai principi fondamentali della Costituzione, che è rigida e quindi si pone al vertice della gerarchia delle fonti, e di sovraordinazione alla legge ordinaria. Ciò significa che se una norma interna è in contrasto col diritto dell’UE, viola l’art. 117 Cost. nella parte in cui, così come modificato dalla legge cost. 3/2001, sancisce che la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali
Il rapporto tra diritto unionale e diritto degli Stati membri non si risolve quindi sulla falsariga del rapporto tra diritto internazionale e diritto interno, cioè in termini di coordinamento tra due sistemi giuridici reciprocamente autonomi che non ammette forme di gerarchia tra norme, poiché è ormai pacifico che l’ordinamento dell’UE necessita, per potersi realizzare, dell’integrazione con gli ordinamenti degli Stati membri. Si tratta pur sempre di un ordinamento autonomo a favore del quale gli Stati membri, aderendovi, hanno rinunciato ai loro poteri sovrani, seppur in settori limitati.
Ne deriva che le norme comunitarie non possono essere intaccate da disposizioni emanate dai singoli Stati e, oltretutto, l’ordinamento giuridico dell’UE garantisce un’applicazione uniforme delle sue norme su tutto il territorio dell’Unione.
L’art. 4 del Trattato sull’Unione europea (TUE, ex Trattato di Maastricht del 1992, da ultimo modificato dal Trattato di Lisbona entrato in vigore nel dicembre 2009) sancisce l’obbligo per gli Stati membri di adottare tutte le misure necessarie volte ad assicurare l’esecuzione degli obblighi derivanti dai trattati o conseguenti agli atti delle istituzioni dell’Unione. Ancora, gli Stati membri si obbligano a collaborare con le istituzioni comunitarie, astenendosi da qualsiasi misura che rischi di mettere in pericolo la realizzazione degli obiettivi dell’Unione (obbligo di leale collaborazione).
Anche nell’ambito della responsabilità degli Stati membri per inadempimento del diritto europeo è ravvisabile una differenza rispetto all’ordinamento internazionale.
Il sistema europeo prevede meccanismi di tutela dell’osservanza delle norme previste dal diritto dell’UE che escludono la possibilità di utilizzare i tradizionali principi seguiti in tema della responsabilità internazionale degli Stati. Due, infatti, sono le procedure che consentono alla Corte di giustizia di pronunciarsi in merito ad un’eventuale responsabilità di uno Stato per inadempimento degli obblighi nascenti dalla loro partecipazione all’Unione, il rinvio pregiudiziale e la procedura di infrazione.
Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, art. 267 TFUE, originariamente concepito al fine di ottenere un’interpretazione delle norme europee, è utilizzato anche nei casi in cui un atto di uno Stato, o il suo mancato intervento, abbiano impedito la corretta applicazione del diritto unionale, provocando danni al singolo individuo. Il rinvio pregiudiziale consente all’istante di adire la Corte passando attraverso il giudice nazionale e, cioè, indirettamente e incidentalmente.
La procedura di infrazione, artt. 258 e ss TFUE, è il metodo classico di contestazione delle infrazioni che può essere azionato dalla Commissione europea o da uno Stato membro allo scopo di garantire l’armonizzazione del diritto europeo e la sua uniforme applicazione. Consente l’accertamento da parte della Corte della non conformità di un determinato comportamento dello Stato agli obblighi dell’Unione e si conclude con una sentenza di mero accertamento dell’esistenza o meno della violazione. In altri termini, la sentenza non può indicare le misure necessarie per far cessare l’inadempimento o stabilire misure per il risarcimento di eventuali danni. Lo Stato, infatti, è solo tenuto a garantire l’effettiva riparazione dell’illecito, attraverso la libera scelta dei mezzi da adottare per provvedere.
Questa procedura ha col tempo rivelato una serie di limiti connessi all’inidoneità a soddisfare le aspettative dei singoli proprio perché l’adempimento dell’obbligo a provvedere, contenuto nella sentenza di condanna, non è garantito da alcun procedimento esecutivo.
A tale limite ha cercato di porre rimedio la Corte nel 1991 con la sentenza Francovich. Grazie a questa pronuncia, se una direttiva non è attuata entro il termine stabilito dalla direttiva stessa, i singoli che abbiano subito un pregiudizio a causa dell’inadempimento dello Stato, possono chiedere a quest’ultimo il risarcimento del danno attraverso un’azione da far valere dinanzi al giudice nazionale.
Questa decisione trova il suo fondamento nel già citato art. 4 del TUE, in forza del quale gli Stati sono tenuti ad adottare tutte le misure necessarie ad assicurare l’esecuzione degli obblighi derivanti dai trattati o conseguenti agli atti delle istituzioni dell’UE.
E’ col progredire e col consolidarsi del processo di integrazione che si è avvertita l’esigenza di garantire un’applicazione uniforme del diritto dell’UE in tutti i Paesi membri.
A ben vedere, la violazione di uno Stato finisce col scalfire la parità di trattamento e il principio di solidarietà all’interno dell’Unione, creando disarmonia e discriminazione in un sistema giuridico che vede tra i suoi obiettivi fondamentali quello della interpretazione e dell’applicazione uniforme delle regole comuni.
Sebbene già precedenti pronunce della Corte di giustizia abbiano accennato alla responsabilità degli Stati per violazione degli obblighi comunitari, è solo con la sentenza Francovich che può ritenersi iniziata a livello europeo una vera e propria ricostruzione sistematica dell’istituto e del relativo regime giuridico.
Nello specifico, con la sentenza Francovich, la Corte ha affermato che se una direttiva non viene attuata nei termini previsti dalla direttiva stessa, lo Stato inadempiente è tenuto a risarcire il danno qualora il risultato da essa prescritto implichi l’attribuzione di diritti a favore dei singoli, il contenuto di tali diritti possa essere individuato sulla base delle disposizioni della direttiva e, infine, sussista un nesso di causalità tra violazione dell’obbligo a carico dello Stato e il pregiudizio subito dai soggetti lesi.
L’affermazione della responsabilità civile dello Stato inadempiente svolge una chiara funzione deterrente, poiché si vuole che gli Stati rispettino con puntualità e diligenza le scadenze a loro poste dagli atti comunitari. La Corte di giustizia, attraverso la stessa interpretazione estensiva dei trattati che ha consentito di applicare l’art. 340 c.2 TFUE ai casi di responsabilità extracontrattuale delle istituzioni comunitarie, ha gettato le basi anche per la disciplina della responsabilità extracontrattuale degli Stati membri per violazione del diritto UE. A differenza del diritto interno, la sentenza Francovich chiarisce che l’elemento psicologico dell’illecito non debba esser provato poiché, essendo la violazione della direttiva chiara e manifesta, la colpa sarebbe in re ipsa. Questo ci fa capire come il modello di responsabilità dello Stato di fronte all’inadempimento comunitario non è riconducibile a stretto rigore al parametro del 2043 cc.
L’accertamento della ricorrenza dei presupposti della responsabilità deve essere svolto alla stregua delle norme comunitarie. Ciò significa che, così come il nesso di causalità tra la violazione dell’obbligo e il danno deve essere accertato secondo le regole del diritto comunitario in tema di responsabilità extracontrattuale, anche l’elemento psicologico andrebbe considerato sulla base del diritto unionale.
Dal canto suo, il giudice nazionale dovrà fare riferimento alle norme di diritto interno per la determinazione dell’entità del risarcimento, la designazione del soggetto passivo dell’obbligo, l’identificazione della procedura giudiziaria e la fissazione dei termini di prescrizione del diritto al risarcimento.
In ogni caso, la determinazione da parte delle legislazioni nazionali delle condizioni formali e sostanziali per il risarcimento del danno non può essere meno favorevole di quella che riguarda analoghe violazioni del diritto interno, né può essere organizzata in modo tale da rendere impossibile o eccessivamente difficile ottenere il risarcimento.
In tal modo emerge un principio di reciproco adattamento tra i due ordinamenti, unionale e interno, nel senso che la responsabilità di fonte comunitaria trova il proprio limite, sul piano degli effetti, nelle disciplina interna, ma su questa incombe il rispetto di uno standard comunitario minimo di tutela. Si è al cospetto di un illecito che non è totalmente comunitario né totalmente nazionale, ma è frutto della commistione tra i due ordinamenti.
Con particolare riferimento all’elemento psicologico dell’illecito, la Corte di giustizia nel 2006, con la sentenza Traghetti del Mediterraneo, ha precisato il tenore del principio della responsabilità dello Stato per violazione del diritto dell’UE da parte di uno dei propri organi giurisdizionali di ultimo grado.
In primo luogo, la responsabilità del magistrato non è da intendersi diversa da quella della responsabilità dello Stato, perché quest’ultimo è da intendere in senso unitario, indipendentemente dal fatto che si tratti di un organo legislativo, esecutivo o giudiziario a porre in essere l’inadempimento.
Per l’ordinamento interno non è possibile ipotizzare una responsabilità dello Stato italiano per la condotta dei suoi organi giurisdizionali, in quanto l’art. 2, numeri 1 e 2, della legge 117/1988 (risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie e sulla responsabilità civile dei magistrati) consente la risarcibilità del danno ingiusto subito per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento solo se posto in essere dal magistrato con dolo o colpa grave nell’esercizio delle sue funzioni o per diniego di giustizia ed esclude la responsabilità nell’esercizio di funzioni giudiziarie in merito all’attività di interpretazione di norme di diritto, o di valutazione del fatto e delle prove.
Secondo l’orientamento della Corte di giustizia, siccome il ruolo delle giurisdizioni superiori è quello nomofilattico, volto cioè ad uniformare l’applicazione delle norme in ambito nazionale, non avrebbe senso escludere i provvedimenti da loro emanati dal novero delle pronunce impugnabili.
E, infatti, proprio perché nell’ordinamento interno queste sentenze non sono suscettibili di impugnazione, l’azione per la responsabilità dello Stato giurisdizione potrebbe rappresentare l’ultimo rimedio in grado di garantire il ripristino del diritto leso e un’adeguata protezione delle prerogative che sono riconosciuti dal diritto comunitario ai singoli cittadini.
E’ chiaro che, posto in questi termini, l’azione di responsabilità dello Stato metterebbe in discussione solo le decisioni degli organi giurisdizionali supremi perché, per quanto riguarda le pronunce dei giudici di rango subordinato, avverso di esse restano esperibili le vie di ricorso interne.
In sintesi, secondo la Corte di giustizia, tutte le volte in cui l’ordinamento italiano esclude la responsabilità dello Stato per i danni arrecati ai singoli a seguito di una violazione del diritto dell’UE imputabile a un organo giurisdizionale interno di ultimo grado, poiché la limita ai soli casi di dolo o colpa grave, viola, al tempo stesso, i principi generali di responsabilità degli Stati membri elaborati dalla giurisprudenza della Corte.
E’ importante chiarire uno specifico aspetto partendo dalle tre condizioni, individuate dalla Corte, in presenza delle quali uno Stato membro è tenuto al risarcimento dei danni causati ai singoli per violazione del diritto dell’UE, vale a dire che la norma giuridica violata sia preordinata a conferire diritti ai singoli, che si tratti di violazione sufficientemente caratterizzata e che esista un nesso causale diretto tra la violazione dell’obbligo incombente allo Stato e il danno subito ai singoli.
La Corte di Cassazione interpreta la nozione di colpa grave, di cui all’art.2 della legge 117/88, in termini di “carattere manifestamente aberrante dell’interpretazione effettuata dal magistrato” e non con la nozione di “violazione manifesta del diritto vigente”, seconda condizione postulata dalla Corte di giustizia ai fini del sorgere della responsabilità dello Stato per violazione del diritto dell’UE.
Nel primo caso non sorgono problemi di sorta nel riconoscere la responsabilità del magistrato, poiché, avendo esercitato la sua funzione con colpa definita grave, è pacifico che risponderà dell’eventuale danno cagionato al singolo. Se, invece, la Corte di Cassazione intendesse per colpa grave anche la violazione manifesta del diritto vigente, allora, a questo punto, l’elemento psicologico dell’illecito non sarebbe da considerare “grave” anche sulla scorta dell’orientamento comunitario, ma rientrerebbe nella seconda delle tre condizioni che, secondo la Corte di giustizia, andrebbero a perfezionare la responsabilità dello Stato per violazione del diritto unionale.
Per quanto riguarda, invece, il tema della violazione di norme comunitarie commessa dalla pubblica amministrazione, è qui che nell’ordinamento interno sorgono i maggiori problemi applicativi per l’accertamento dell’elemento soggettivo dell’illecito.
Punto di partenza è l’art.30 c.p.a., ai sensi del quale può essere chiesta la condanna al risarcimento del danno ingiusto derivante dall’illegittimo esercizio dell’attività amministrativa o dal mancato esercizio di quella obbligatoria. Sul versante soggettivo, la norma prescrive la sussistenza di dolo o colpa della P.A. con esclusivo riferimento all’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento.
E’ chiaro che il richiamo al paradigma dell’ingiustizia evidenzia l’adesione al modello di responsabilità aquiliana che, nell’ordinamento interno, richiede la sussistenza dell’elemento soggettivo.
Quindi, una volta riscontrata l’effettiva verificazione del danno ingiusto, il giudice dovrà valutare ai fini risarcitori anche la sussistenza dell’elemento soggettivo della P.A. ed è proprio sui criteri di accertamento del dolo o della colpa che la questione è stata oggetto di una serie di dibattiti in dottrina e in giurisprudenza, che ne hanno proposto soluzioni diverse.
Punto di partenza è costituito dalla sentenza della Cassazione a Sezioni Unite numero 500/99.
In questa sede la Cassazione ha superato l’orientamento di derivazione penalistica secondo il quale l’illegittimità del provvedimento, in quanto violazione di norme che regolano l’azione amministrativa, implica già di per sé l’integrazione dell’elemento soggettivo dell’illecito.
Afferma, invece, che l’imputazione della responsabilità extracontrattuale in capo alla P.A., lungi dal conseguire al mero dato obiettivo dell’illegittimità dell’azione amministrativa, richiede anche l’accertamento in concreto della colpa della P.A. intesa come apparato.
La svolta consiste, da un lato, nell’indicazione dell’”apparato” quale soggetto in capo al quale va rintracciato l’elemento psicologico, superando così l’idea che oggetto di indagine dovesse essere il singolo funzionario, dall’altro, nel considerare la colpa come violazione delle regole di imparzialità, correttezza e buona amministrazione.
Solo che è stato evidenziato che la violazione dei principi d’imparzialità, correttezza e buona amministrazione, considerato dalla Cassazione indici sintomatici della sussistenza della colpa d’apparato, si risolve nell’illegittimità del provvedimento amministrativo per eccesso di potere, ricadendo in tal modo nell’equivalenza illegittimità/colpa, che invece la Cassazione ha proprio cercato di evitare.
Anche il riferimento al criterio della violazione delle regole di buona amministrazione è stato criticato perché potrebbe far intendere che un provvedimento anche solo inopportuno potrebbe assurgere a presupposto per la responsabilità della P.A.
In considerazione di queste critiche, la giurisprudenza ha cercato di meglio definire l’elemento soggettivo della responsabilità della P.A. per illegittima attività provvedimentale.
Un ruolo rilevante in tal senso è stato ricoperto dalla giurisprudenza comunitaria nel 2010, al punto da influenzare l’ordinamento interno talmente profondamente da indurre parte della dottrina a ritenere che la responsabilità della P.A. abbia natura esclusivamente oggettiva.
La Corte di giustizia si è espressa a tal proposito sul tema dei contratti pubblici, con particolare riferimento al danno da aggiudicazione illegittima, ricostruendo la responsabilità della P.A. in chiave oggettiva per la sola inosservanza, grave e manifesta, di disposizioni comunitarie attributive di diritti, dalla cui violazione derivi un danno i via direttamente consequenziale.
Prima di indagare in che modo il giudice nazionale abbia recepito le indicazioni della Corte di giustizia, è opportuno fare riferimento alle tecniche di tutela previste nel c.p.a. e al ruolo che in questo settore ricopre la responsabilità risarcitoria.
Gli artt. 121 e ss. c.p.a. prevedono una serie di ipotesi nelle quali il giudice deve (o può, a seconda della gravità della violazione commessa) dichiarare l’inefficacia del contratto illegittimamente aggiudicato, disponendone l’attribuzione in favore del ricorrente.
Ancora, l’art. 124, c.1, c.p.a., prevede o la possibilità di ottenere il ristoro in forma specifica mediante il conseguimento dell’aggiudicazione del contratto oppure un risarcimento per equivalente. Infatti, nel caso in cui il giudice non disponga in favore del ricorrente il bene della vita illegittimamente attribuito ad altri, è previsto che all’avente diritto l’aggiudicazione sia assicurato il ristoro per equivalente dei danni subiti, dei quali abbia fornito adeguata prova durante il giudizio.
Per la Corte di giustizia, laddove non venga dichiarata l’inefficacia del contratto e, quindi, non venga riconosciuta la tutela in forma specifica, il giudice deve riconoscere al ricorrente, d’ufficio e senza necessità di provare l’elemento soggettivo, il risarcimento del danno subito e provato.
Ciò in quanto, secondo la Corte, il rimedio per equivalente non sarebbe un’alternativa valida rispetto alla tutela in forma specifica (il conseguimento dell’aggiudicazione), per il semplice fatto che il rimedio per equivalente non costituisce un risarcimento in senso stretto, ma una misura sostitutiva della forma specifica.
In altri termini, si tratta non di una domanda risarcitoria tout court, ma dell’accoglimento della domanda di esatto adempimento proposta dal ricorrente che chiede al giudice l’aggiudicazione del contratto, con la mera sostituzione del bene della vita agognato col suo surrogato economico.
Di conseguenza, non è necessario provare l’elemento psicologico né proporre una nuova domanda.
Per la Corte, una norma nazionale non può subordinare il risarcimento danni derivanti da violazioni della P.A., commesse nel corso di gare d’appalto, al carattere colpevole di tale violazione.
La responsabilità in materia di appalti, dunque, si configura come oggettiva, con la conseguente impossibilità, per la stazione appaltante, di dimostrare il carattere incolpevole della violazione accertata dal giudice, magari dimostrando la scusabilità dell’errore ed escludendo, così, il risarcimento per equivalente del danno.
Secondo parte della dottrina, la decisione della Corte di Giustizia mette seriamente in discussione tutta l’elaborazione giurisprudenziale nazionale, rigorosa nel ritenere che la responsabilità della P.A. da provvedimento illegittimo integra un’ipotesi di responsabilità per colpa.
Ciò in quanto (sempre secondo questo orientamento dottrinale) nonostante la Corte si sia pronunciata nell’ambito della violazione della normativa comunitaria sugli appalti, il principio ivi affermato dovrebbe avere portata generale, altrimenti si ammetterebbe una domanda risarcitoria dell’interesse legittimo mutevole quanto a intensità e a presupposti, in funzione del tipo di norma violata e della materia cui essa si rivolge.
Il ragionamento seguito da questo filone interpretativo ha avuto conferma subito dopo, nel 2011, con la poc’anzi citata sentenza della Corte di Giustizia che ha condannato l’Italia per incompatibilità della legge nazionale sulla responsabilità dei magistrati col principio comunitario della responsabilità (oggettiva) degli Stati membri per violazioni del diritto comunitario riferibili a organi giurisdizionali di ultima istanza.
Il Consiglio di Stato, tuttavia, nel 2012 si mostra di contrario avviso, ritenendo che il principio della responsabilità oggettiva della P.A., così come enunciato dalla Corte di giustizia, si riferisca esclusivamente al settore degli appalti pubblici. Questo orientamento giurisprudenziale si poggia su due argomentazioni.
La prima si fonda sul fatto che la normativa interna sui contratti pubblici richiama pedissequamente quella europea, poiché particolarmente specifica in materia di ricorsi aventi ad oggetto procedure di aggiudicazione.
La seconda, in realtà collegata alla prima, fa leva sulla particolare attenzione che l’Unione europea riserva alla materia per la sua attitudine a incidere sul corretto funzionamento del mercato e della concorrenza